Durante il settembre del 1915 la città di
Vercelli e il giornale La Sesia si
erano interessati alla storia di un soldato romano, giunto nel vercellese per
essere ricoverato all'ospedale militare per le ferite riportate in battaglia.
Il suo nome era Felice Zampini, giovane
militare reduce già dalla guerra in Libia e che aveva subito l’amputazione di
entrambe le mani a seguito dello scoppio di una bomba austriaca al fronte. La
situazione dello Zampini porta a lui molte simpatie dalla cittadinanza, che grazie
al giornale La Sesia decide di aprire
una sottoscrizione a suo favore e nel giro di qualche giorno vengono raccolte
1.500 lire, che permettono ai medici di acquistare e installare due protesi che
possano aiutare il soldato nella vita civile. A mesi di distanza il giornale
torna a dare notizie sulla sorte di Felice Zampini e sulla sua sorte. «Abbiamo,
un giorno, pubblicato un ritratto dello Zampini coi due moncherini – spiega il
giornale ai suoi lettori -; ne pubblichiamo oggi un altro, dove il bravo
soldato è fotografato con le mani artificiali che gli tengono il posto di
quelle sfracellate dalla bomba nemica ed
amputate» (La Sesia, 31 marzo '16). La foto ritrae il soldato Zampini con in mano
una bottiglia di vino e nell'altra il bicchiere. Questa è una cosa che sorprende
il giornale visto che «tutti sanno come la mano negli antichi apparecchi non
serva che per figura – anzi per alcuni l’apparecchio – è più un ingombro che un’utilità. Si capisce poi in quali pietose condizioni si trovi un individuo, al quale manchino tutte e due le mani, che deve avere un aiuto per i bisogni più comuni e più intimi».
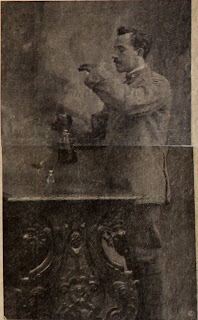 Ma per il soldato Zampini il prof. Isnardi,
direttore dell’ospedale militare, grazie ai soldi giunti dalla sottoscrizione e
dal finanziamento giunto dalla Cassa di risparmio «dopo varie prove poté far
preparare dall'operaio vercellese Ramagni due arti coi quali il mutilato di
ambe le mani può prendere una bottiglia con una mano artificiale, togliere il
tappo, nascere il contenuto nel bicchiere, deporre la bottiglia, e coll'altra mano afferrare il bicchiere, portarlo alla bocca, bere e deporlo al suo posto.
Così può usare cucchiaio e forchetta, abbottonarsi e sbottonasi la giacca, il
gilè ed i pantaloni senza l’aiuto di alcuno. Nello stesso modo e con
disinvoltura e precisione di movimenti, è capace di stringere la mano, di
ritirare un libro dal tavolo, reggere una sedia (…) E la forza, essendo data
dai potenti muscoli del braccio, si può durare molto a lavorare senza risentire
stanchezza». Grato, quindi, per ciò che è stato fatto per lui il soldato aveva
inviato una fotografia al giornale e alla città che tanto avevano fatto per lui
e per la sua salute. E il giornale la pubblica, allegando i complimenti al
professor Isnardi e soprattutto all’ortopedico Ramagni, costruttore di un apparecchio
“semplicissimo” e, soprattutto, servibile.
Ma per il soldato Zampini il prof. Isnardi,
direttore dell’ospedale militare, grazie ai soldi giunti dalla sottoscrizione e
dal finanziamento giunto dalla Cassa di risparmio «dopo varie prove poté far
preparare dall'operaio vercellese Ramagni due arti coi quali il mutilato di
ambe le mani può prendere una bottiglia con una mano artificiale, togliere il
tappo, nascere il contenuto nel bicchiere, deporre la bottiglia, e coll'altra mano afferrare il bicchiere, portarlo alla bocca, bere e deporlo al suo posto.
Così può usare cucchiaio e forchetta, abbottonarsi e sbottonasi la giacca, il
gilè ed i pantaloni senza l’aiuto di alcuno. Nello stesso modo e con
disinvoltura e precisione di movimenti, è capace di stringere la mano, di
ritirare un libro dal tavolo, reggere una sedia (…) E la forza, essendo data
dai potenti muscoli del braccio, si può durare molto a lavorare senza risentire
stanchezza». Grato, quindi, per ciò che è stato fatto per lui il soldato aveva
inviato una fotografia al giornale e alla città che tanto avevano fatto per lui
e per la sua salute. E il giornale la pubblica, allegando i complimenti al
professor Isnardi e soprattutto all’ortopedico Ramagni, costruttore di un apparecchio
“semplicissimo” e, soprattutto, servibile. 



